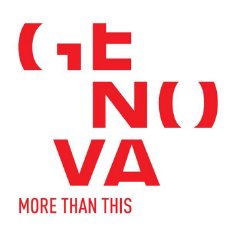TOUR
-------------------------------------------------------------
I GENOVESI
Palazzo Bianco ospita la più vasta rassegna di pittura genovese e ligure che sia possibile ammirare in un museo pubblico.
Alle collezioni esposte nelle dodici sale Galleria, che coprono soprattutto l’arco cronologico che va dal XV al XVIII secolo, con qualche interessante anticipazione medievale (XIII-XIV secolo), si aggiungono quelle del deposito, che consta di diciotto sale che presto verranno aperte al pubblico.
Luca Cambiaso è il primo protagonista del percorso espositivo. Davvero significativa la selezione: alle raffinate opere della prima maturità si affiancano quelle ispirate alla lezione veneziana e quelle della fase finale della sua attività (celeberrima è la Madonna della candela) concentrate e semplificate nelle forme, esempi di mirabile "preghiera per immagini".
Seguono le opere degli altri protagonisti della scena genovese nella seconda metà del ‘500 – Giovan Battista Castello il Bergamasco, Lazzaro Tavarone, Andrea Semino – e dei maestri della pittura locale di primo ‘600: dipinti di Giovan Battista Paggi, di Andrea Ansaldo, di Luciano Borzone (da segnalare soprattutto il luminoso e raffinato Battesimo di Cristo), di Domenico Fiasella.
Chiude il percorso del primo piano una sezione dedicata al ritratto a Genova nel XVII secolo, con – tra le altre – due tele di Giovanni Battista Gaulli detto il Baciccio, personalità di fama europea, protagonista della scena romana nel solco del barocco berniniano.
Al terzo piano, la sala dedicata a Bernardo Strozzi propone una corposa rassegna della produzione del grande artista del primo Seicento genovese: a una dolente e raffinata Maddalena, rivelatrice della predilezione di Strozzi per l’arte lombarda coeva, fa riscontro un’elegante Santa Cecilia e la grandiosa Gloria di santa Teresa, una fra le rare pale d’altare da lui dipinte per Genova, rutilante di colori caldi e materici.
Gioacchino Assereto è rappresentato al meglio della sua arte: da un lancinante, giovanile San Francesco al Cristo deriso, grandiosamente procaccinesco e rubensiano, alla vasta tela col Suicidio di Catone Uticense, corrusco episodio di teatro barocco tradotto in pittura.
Si segnala, inoltre, la Giustizia di Giovanni Andrea De Ferrari (splendida per le accese cromie), cui fanno seguito tele di Silvestro Chiesa (noto per il Miracolo del beato Piccolomini), di Orazio De Ferrari, di Gio. Benedetto Castiglione detto il Grechetto, Sinibaldo Scorza, Anton Maria Vassallo e Antonio Travi, accanto a bozzetti di Giovanni Battista Carlone, celebre frescante.
La sala riservata a due fra i più celebri maestri del pieno Seicento genovese, Valerio Castello, offre al visitatore una splendida rassegna di opere: tra le quali si vuole menzionare il grande Martirio di san Lorenzo, il Mosè bambino e la prova dei carboni ardenti e la delicata Madonna del velo. Segue la grande stagione barocca di Casa Piola: di Domenico Piola sono esposte opere di equilibrio classico e raffinata gamma cromatica, come l’Ateneo delle Belle Arti, accanto a bozzetti per affresco come l’Incoronazione della Vergine, preparatorio per la decorazione della cupola della chiesa genovese di San Luca; del figlio Paolo Gerolamo Piola si presentano ancora un notevole numero di bozzetti di piccolo formato, legati alla sua attività di frescante.
Nelle sale di Palazzo Tursi il percorso prosegue con il genero di Domenico, Gregorio De Ferrari, del quale si segnala il mosso Noli me tangere e La Samaritana al pozzo, e con i ‘preziosi’ quadri di Bartolomeo Guidobono, ricercati nelle brillanti cromie messe in risalto dalla luce e nell’attenzione ai dettagli.
Queste opere concludono la stagione seicentesca e aprono il XVIII secolo, documentato da ritratti (un gigantesco doge del Mulinaretto), da paesaggi (Tavella) e soprattutto dal ricchissimo nucleo di undici opere di Alessandro Magnasco, in cui spiccano veri capolavori, come il giovanile San Francesco in estasi, un minuscolo Cristo nell’orto degli ulivi e, soprattutto, il Trattenimento in un giardino d’Albaro, vero e proprio "pezzo unico", affascinante immagine della vita aristocratica settecentesca che animava Genova, abbracciata dal pittore in una larga e dettagliata panoramica.
-----------------------------------------------
FIAMMINGHI
Le collezioni di pittura fiamminga di Palazzo Bianco, conosciute in tutto il mondo per l’eccezionale qualità, coprono un arco cronologico che va dalla fine del Quattro al primo Settecento, occupando quattro sale della Galleria e altre quattro del deposito. Ulteriore peculiarità che contraddistingue le opere di questo nucleo è quella di essere state dipinte proprio per Genova, o a Genova, e di trovarsi nella Superba da antica data.
Fa eccezione certamente il Cristo benedicente di Hans Memling ad inizio percorso, un’opera indimenticabile per concentrazione drammatica, magistrale minuzia di esecuzione e misurata sapienza prospettica.
Nella stessa sala, quattro tavole di un ignoto maestro bruggese, con Storie di San Giovanni Evangelista e autentici capolavori di Gerard David (quattro scomparti del grandioso Polittico della Cervara, tra i quali l’assorta Madonna dell’uva, la strepitosa Crocifissione).
Joos van Cleve è presente con la Madonna col Bambino, di raffinato disegno e di smaltata intensità cromatica; Jan Provost con due tavole raffiguranti San Pietro e Santa Elisabetta d’Ungheria e con la gigantesca Annunciazione, ambientata in un interno domestico fiammingo, costellato dalla presenza di oggetti dal preciso significato simbolico e allegorico.
L’intreccio fra tradizione fiamminga e suggestioni rinascimentali italiane, avvenuto nella città di Anversa nel primo Cinquecento, è rappresentato da un trittichetto di Pieter Coeck van Aelst raffigurante l’Adorazione dei Magi e da due tavole di Jan Massijs, una Madonna col Bambino (1552, sua prima opera datata) e un’elegantissima Carità.
Quest’ultime appartenevano già nel XVI secolo alla stessa collezione genovese di Gerolamo Balbi, nella quale figuravano le due grandi tavole che oggi spiccano, brillanti per cromie, alla parete adiacente: la Cuoca e il Mercato sono scene di genere, tipiche della tradizione pittorica instauratasi nei Paesi Bassi Settentrionali dopo la Riforma protestante.
Questi dipinti furono di fondamentale importanza per la formazione dei pittori genovesi del primo Seicento (Strozzi, a esempio), che poterono così vederle e studiarle.
Van Dyck e Rubens dominano la sala 18: del primo è un capolavoro del periodo genovese (1621-1627), il Vertumno e Pomona, in cui l’artista mostra di guardare all’arte veneta del secolo precedente; di Peter Paul Rubens, vero genio creatore del Barocco europeo, un’opera matura e sensuale, un Venere e Marte che affascina per la ricchezza della stesura pittorica, perfettamente conveniente al soggetto raffigurato.
Accanto a Van Dyck, il suo grande collaboratore Jan Roos, maestro della natura "in posa": fiori, frutta e ortaggi che nella Vendemmia di Sileno sono vibranti e vivaci complementi della composizione e nella Natura morta, invece, protagonisti assoluti ed eloquenti.
Il grande afflusso di artisti fiamminghi nella Genova del primo Seicento è documentata poi dalle opere esposte nella sala successiva: si segnala un paesaggio di Jan Wildens, un Ritratto femminile di Guilliam van Deynen, realizzato a Genova nel 1610, e, soprattutto, le due splendide Opere di Misericordia (dipinte da quello che divenne il "capo" riconosciuto della colonia di pittori fiamminghi a Genova, Cornelis de Wael) caratteristiche per l’ambientazione in luoghi reali della città, come l’ospedale e il carcere per i debitori.
Nella stessa sala, si possono ammirare esempi della pittura olandese del pieno e del tardo Seicento, variegata per i nomi degli artisti e per i soggetti raffigurati : La Pasqua fiorita di Jan Steen spicca per qualità, accanto all’affascinante Paesaggio notturno su rame di Aert van der Neer e ai Conigli sullo sfondo di Anversa, piccolo capolavoro di Aelbert Cuyp, nel quale un abile gioco prospettico trasforma l’immagine di natura in un inconsapevole annuncio delle atmosfere surrealiste.
---------------------------------------------------------
I GIARDINI DI STRADA NUOVA E IL PANORAMA DI GENOVA DALLE TERRAZZE
I Musei di Strada Nuova offrono ai visitatori una sorprendente e del tutto inedita corona di cortili, giardini e terrazze posti a diverse quote e diversi per carattere. In Palazzo Rosso, oltre il seicentesco cortile porticato, si apre un secondo cortile - tra le case del centro medievale, cinto da un muro di confine – la cui realizzazione si colloca nell’ambito dei rilevanti interventi di restauro della dimora promossi alla metà del secolo scorso dall’architetto razionalista Franco Albini e dall’allora direttrice del civico Ufficio Belle Arti, Caterina Marcenaro: il progetto di questa nuova area sul retro dell’edificio storico intendeva ‘evocare’ lo spazio di un giardino seicentesco, storicamente non documentato nel palazzo dei Brignole Sale ma certamente elemento consueto nella cultura abitativa genovese.
Due moderni pergolati fanno da cornice ad un portale settecentesco proveniente dall’oratorio del distrutto complesso conventuale di San Silvestro, mentre sulla destra del cortile è murata un’edicola seicentesca con una statua raffigurante la Vergine Regina di Genova, eletta sovrana della città nel 1637. Al piano nobile del palazzo, una terrazza corona invece fin dalle origini la struttura del cosiddetto Palazzetto, offrendo la possibilità di ammirare suggestivi scorci sul giardino di Palazzo Bianco, dal lato opposto di Strada Nuova, e sulla vicina settecentesca via Cairoli.
Infine un moderno ascensore panoramico consente al pubblico di accedere direttamente al tetto del palazzo, dal quale godere un’impareggiabile vista sull’intera città, dalle colline al mare.
Palazzo Bianco possiede due giardini a diversi livelli: il primo, più piccolo, cui si accede dalla prima sala del museo, ha mantenuto l’impianto settecentesco con parterre, percorsi a risseu e fontane, e confina con l’attiguo giardino di Palazzo Tursi, che conserva un bell’albero d’alto fusto.
Il secondo, visibile nel passaggio verso lo stesso Palazzo Tursi, conserva invece visibili i resti monumentali di quella che fu una delle maggiori chiese gotiche cittadine, San Francesco di Castelletto, demolita definitivamente intorno al 1820 con la dispersione di notevolissimi tesori, in parte ricoverati in altre sedi. Di questa chiesa, che insieme al convento contiguo costituiva una delle più importanti fondazioni religiose della Genova medievale, sono ancora visibili arcate e colonne a rocchi bianchi e neri di una navata, letteralmente inglobate nella facciata dell’ottocentesco palazzo comunale retrostante il museo. Dello stesso complesso di San Francesco sono inoltre riemersi, nel corso degli scavi archeologici intrapresi in vista di Genova Capitale Europea della Cultura 2004, elementi architettonici e decorativi che, parte integrante del polo museale di Strada Nuova, saranno per i visitatori preziosa testimonianza della storia della città.
Un altro giardino, su due livelli, si trova infine sul lato a levante di Palazzo Tursi, verso Palazzo Lomellino.