
Clicca qui per visualizzare l'immagine
Santo Varni (Genova, 1807-1885)
Marmo, cm 85 x 90 x 62
Firmato e datato sulla base "Per commissione di S.A.R. il principe Odone di Savoia S.Varni genovese MDCCCLVIII" (1858-1865)

Clicca qui per visualizzare l'immagine
Santo Varni (Genova, 1807-1885)
Marmo, cm 85 x 90 x 62
Firmato e datato sulla base "Per commissione di S.A.R. il principe Odone di Savoia S.Varni genovese MDCCCLVIII" (1858-1865)


Clicca qui per visualizzare l'immagine
François Marius Granet (Aix-en-Provence, 1775-1849)
Olio su tela, cm. 100,5 x 81,5
Firmato in basso a sinistra "Granet"


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Léopold Robert (Les Eplatures, 1794 - Venezia, 1835)
Olio su tela, cm. 90 x 76

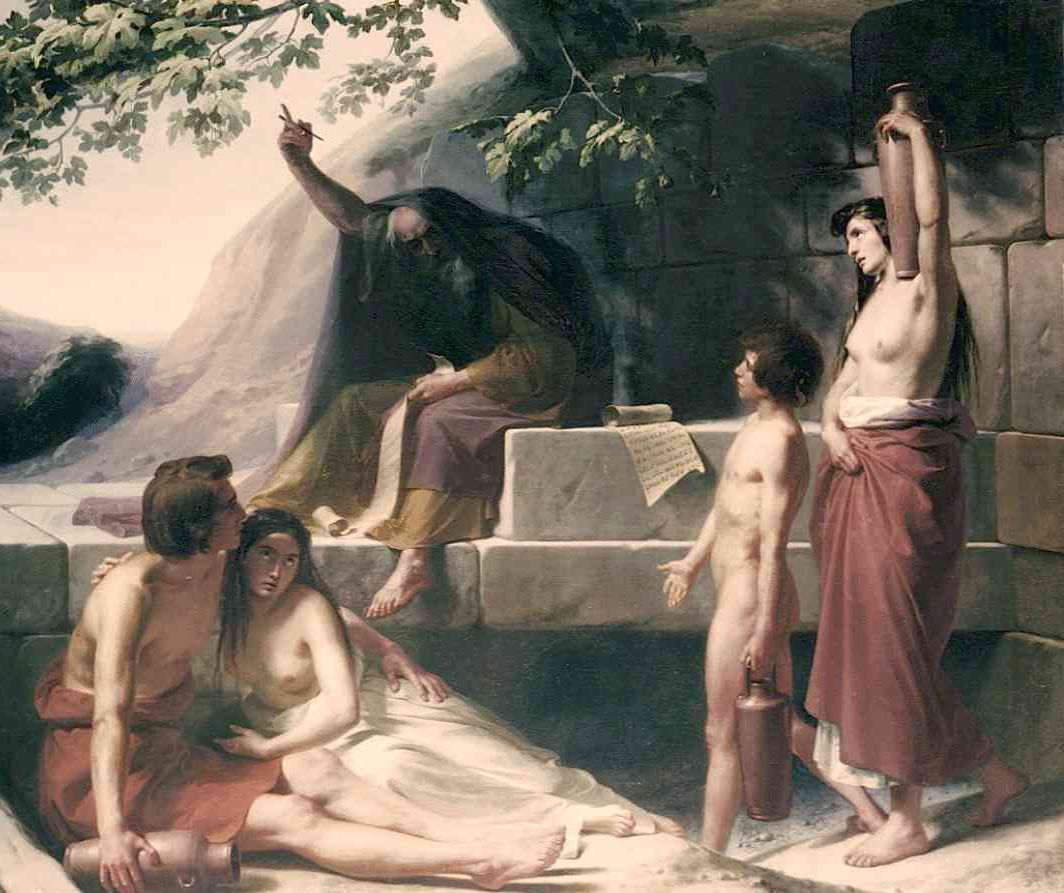
Clicca qui per visualizzare l'immagine
Carlo Arienti (Arcore, 1801 - Bologna, 1873)
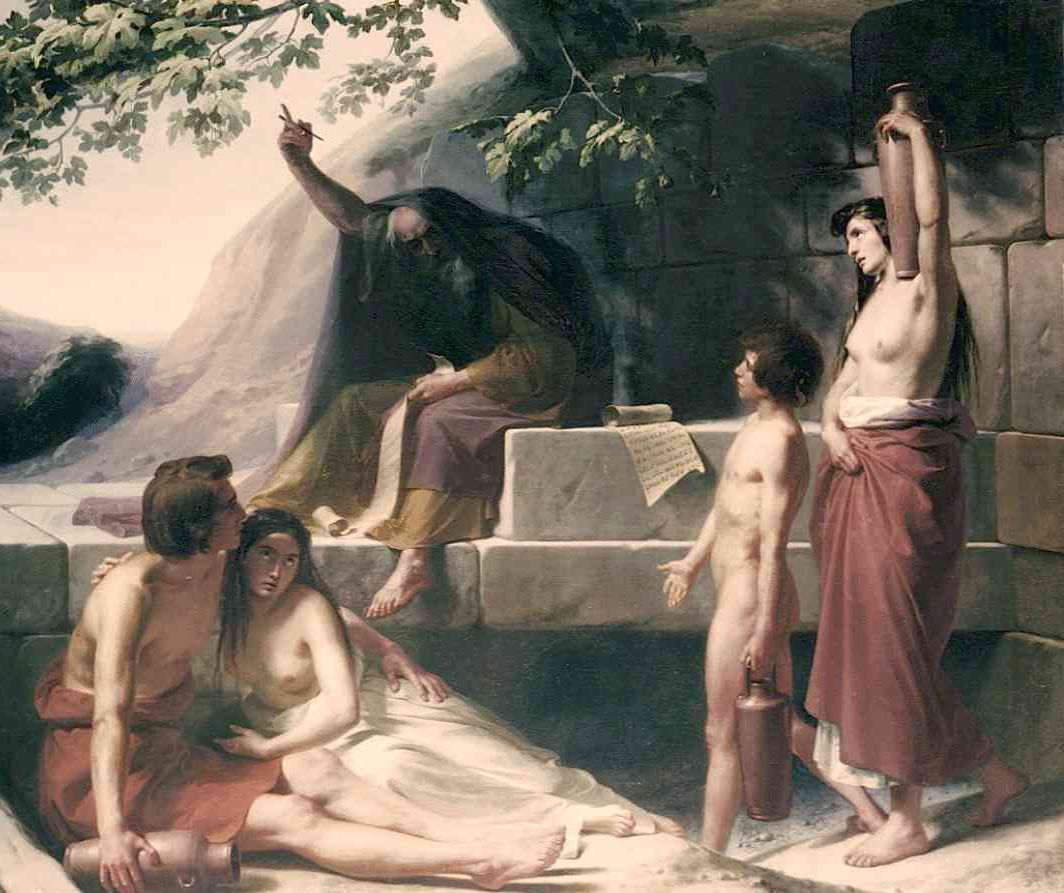

Clicca qui per visualizzare l'immagine
Santo Varni (Genova, 1807-1885)
Bozzetto di terracotta, cm. 39,5 x 14 x 11,5


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Nicolò Traverso (Genova, 1745-1823)
Bozzetto


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Giuseppe Frascheri (Savona, 1809 - Genova, 1886)
Olio su tela, cm. 282 x 179,8
Soggetto dantesco dalle calde cromie ispirato alle opere di Ary Scheffer.
Esposto alla mostra dell'Accadenia Ligurstica di Belle Arti di Genova organizzata in occasione dell'VIII Congresso Scientifico Italiano nel 1846.


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Veduta di Genova
Lunganelli, Elbano 1974 RM/ Roma - donazione
Bossoli, Carlo
dipinto
1872 - 1872 - XIX
GAM1981
Unità di misura: cm; Altezza: 39; Larghezza: 70.5; Varie: Altezza con cornice cm 58.5
Larghezza con cornice cm 90
olio su cartone
Veduta di Genova dai monti retrostanti, realizzata a olio.


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Ippolito Caffi (Belluno, 1809 - Lissa, 1866)
Olio su tela, cm. 54 x 82
Smaltata e limpida veduta di Genova del 1850 del veneto Ippolito Caffi (Belluno 1809 - Lissa 1866), costretto a riparare in Liguria tra il 1849 e il 1854 per ragioni politiche.
Firmato e datato in basso a destra "Ippolito Caffi pinse 1850"


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Veduta fantastica dei principali Monumenti d'Italia
1898 Genova - acquisto
Tetar Van Elven, Petrus Henricus Theodor
dipinto
1858 - 1858 - XIX
GAM 471
Unità di misura: cm; Altezza: 252; Larghezza: 353
olio su tela
Concepito in apparenza come un grandioso “collage” di tutti i monumenti simbolo delle più importanti città italiane per evitare problemi di censura, ma in realtà pensato come una sorta di pre-manifesto risorgimentale dell’Unità d’Italia, il dipinto prende l’avvio dalla parziale veduta della Lanterna di Genova, all’estrema sinistra, per riunire, attraverso le architetture più riconoscibili e simboliche della penisola – dal duomo di Milano, a San Marco di Venezia, dalla torre di Pisa a San Pietro in Vaticano fino al fumante Vesuvio sulla baia di Napoli - tutta l’Italia sotto la bandiera sabauda. Manca la raffigurazione della Sicilia perché Giuseppe Garibaldi sarebbe partito coi mille volontari, per annetterla al Regno d’Italia, solo due anni dopo, il 5 maggio 1860.
La grande tela, realizzata dall’olandese Petrus Henricus Theodor Tetar van Elven, uno degli artisti più vicini alla dinastia regnante dei Savoia, è appartenuta al Marchese di idee mazziniane Filippo Ala Ponzone. Questa veduta riunisce tutti i monumenti simbolo delle più importanti città italiane. Sulla sinistra c'è la parziale veduta della Lanterna di Genova, per poi proseguire con altre architetture simboliche: il duomo di Milano, la Basilica di San Marco di Venezia, la torre di Pisa e San Pietro in Vaticano. Sulla destra è dipinto il Vesuvio affacciato sulla baia di Napoli.


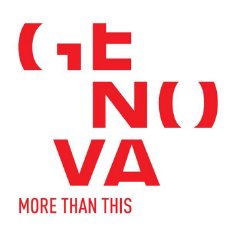

Sede:
Comune di Genova - Palazzo Tursi
Via Garibaldi 9 - 16124 Genova
C.F. / P.iva 00856930102