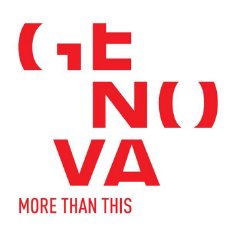Clicca qui per visualizzare l'immagine
Patera
Re Vittorio Emanuele II 1866 donazione
Pittore del Louvre, Lucania, IV secolo a.C.
Patera
IV a.C. - 450 a.C. - 300 a.C.
Unità di misura: cm; Altezza: 13; Diametro: 42; Varie: Diametro piede 15
argilla rossa- verniciatura
Odone di Savoia 1846-1866 le collezioni di un Principe per Genova - Genova - 1996
Questo grande piatto dipinto a più colori è stato realizzato da un pittore apulo, detto Pittore del Louvre, attivo in Italia Meridionale tra il 325 e il 300 a.C. Le scene sulle due facce riportano soggetti legati al culto di Dioniso, il dio del vino: un satiro con strumento musicale e grappolo d'uva, una seguace del dio con corona di fiori, amorini alati e figure maschili e femminili con i vari simboli di Dioniso, corone, grappoli, tirsi. Un vero capolavoro di armonia fra la forma del vaso, i colori, le figure e gli elementi di decorazione floreale. Fa parte della collezione del Principe Oddone di Savoia che comprende numerosi pezzi di grande bellezza e, soprattutto fra le ceramiche dipinte di età greca ed ellenistica, capolavori attribuiti ai più grandi artisti del mondo antico. Il piatto a vernice nera ha sulla superficie figure rosse dipinte e decorate con sovra dipintura in bianco, giallo, rosa. L'esterno è caratterizzato da un motivo a meandro e da scene figurate con motivi decorativi fitomorfi; questi ultimi ornano anche l'orlo della ceramica. Le anse laterali nastriformi sono sormontate da un bottone a stelletta bianca che si ripete nei lati. Il bordo delle anse è ripiegato all'esterno. L'interno del piatto a forma circolare è caratterizzato da decorazioni a meandro e scene figurate. Intorno alla parte centrale dell'interno il piatto presenta motivi decorativi fitomorfi.