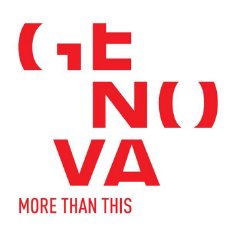Clicca qui per visualizzare l'immagine
Manifattura genovese del XVI secolo
Tessile
Ricamo in raso e seta
L’opera, del 1564 circa, è uno dei pochi esempi di ricamo genovese cinquecentesco di cui si conosce la committenza e la storia. I Padri del Comune infatti ordinarono a Ottavio Semino sedici cartoni destinati ad ornare il baldacchino della processione del Corpus Domini per il quale venne inoltre richiesta una cassa alla quale realizzazione parteciparono Luca Cambiaso, Bernardo Castello, Perin del Vaga ed Ottavio Semino. Il prezioso ricamo, di cui rimangono le figure dei quattro Evangelisti, venne affidato a Francesco de Ursis che lo realizzò in raso dipinto, ricami in seta e ricami applicati per le cornici.