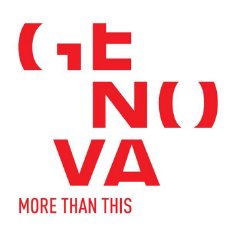Precedentemente attribuito alla bottega di Barnaba da Modena o a un anonimo, oggi il dipinto è concordemente inserito nel corpus di opere dell'artista modenese, come attestato dall'iscrizione posta nella parte inferiore della tavola centrale. Durante il restauro del 1985 non è stato possibile recuperare la data di esecuzione (Tagliaferro 1991, p. 64). A questo proposito, Franco Pesenti ritiene che l'opera sia stata realizzata intorno al 1370, mentre Giuliana Algeri, Laura Tagliaferro e Clario Di Fabio hanno posticipato la datazione di circa un decennio. Questi ultimi, infatti, identificano nei due donatori rappresentati negli scomparti laterali il Doge Nicolò Guarco e la moglie Lina di Francesco Onza d'Oro di Coronata (Pesenti 1987, p. 56; Algeri 1991, pp. 90-91; Tagliaferro 1991, pp. 64-65; Di Fabio 1999, p. 62). Il polittico proviene dalla chiesa di SS. Giacomo e Filippo, cui probabilmente era stato destinato dai committenti, come confermerebbero la presenza di una santa domenicana, di Santa Caterina d'Alessandria, patrona dei Domenicani, e di San Nicola di Bari, il cui braccio era conservato nel convento genovese. Problematiche sono l'identificazioni delle due sante raffigurate nelle cuspidi laterali. Secondo Laura Tagliaferro la santa domenicana potrebbe essere Margherita d'Ungheria, Sant'Agnese da Montepulciano o Santa Caterina da Siena, mentre Giuliana Algeri e Clario Di Fabio proponendo per la prima ipotesi. La santa della cuspide sinistra è invece variamente identificata come una vergine del seguito di Sant'Orsola, come Santa Margherita di Antiochia o genericamente come una santa martire (Algeri, 1991, pp. 90-91; Tagliaferro 1991, p. 65; Di Fabio 1999, p. 62). La pala d'altare è suddivisa in tre scomparti, centinati, lobati e sormontati da cuspidi mediante colonnine. Nello scomparto centrale è rappresentata la Madonna col bambino. La Vergine, girata di tre quarti a sinistra e con lo sguardo rivolto verso l'osservatore, indossa una veste rosso scuro e un mantello blu, di cui si intravede la parte interna color oro; un velo trasparente le cinge il capo e ricade sul petto formando un soggolo. Avvolge il Bambino col braccio destro e lo regge con l'altra mano. Gesù, vestito con una tunica rosa bordata sull'orlo da un gallone dorato, accarezza con la mano destra un cardellino posato sul suo braccio sinistro. In basso un'iscrizione a caratteri d'oro recita: "BARNABAS DE MUTINA PINXIT...". Nello scomparto destro San Nicola di Bari è rappresentato in piedi, in abiti vescovili, rivolto verso la Madonna e il Bambino. Il santo regge un libro nella mano sinistra e il pastorale nella destra. Ai suoi piedi è inginocchiato il donatore, raffigurato di profilo con le mani giunte, in abiti rossi e con un copricapo dello stesso colore. Nella cuspide al di sopra una santa martire coronata vestita di un abito e un mantello rosa è rivolta verso la cuspide centrale, con le mani giunte. Nello scomparto sinistro, Santa Caterina d'Alessandria tiene la palma del martirio nella mano destra e un libro aperto nella sinistra. La santa, velata, indossa un abito blu con quattro bottoni sul petto e un manto rosa bordato di oro. Ai suoi piedi è raffigurata la donatrice, una giovane inginocchiata dai capelli biondi, con abito e mantello rosso e oro e le mani giunte; anch'essa è rivolta verso la tavola centrale. In alto, una santa domenicana tiene un crocifisso nella mano sinistra e un cuore nell'altra mano; lo sguardo è rivolto verso la cuspide centrale dove sono rappresentati Cristo crocifisso, la Madonna e San Giovanni Evangelista. Quest'ultimo, con una veste blu e il mantello rosa, è inginocchiato accanto alla croce con il busto piegato in avanti. Dalla parte opposta la Madonna, con la fronte coperta dal mantello, è seduta e ha il capo rivolto verso sinistra. Indica con la mano destra Cristo, rappresentato con un perizoma bianco e il capo reclinato verso la spalla destra, inchiodato a una croce con un suppedaneo in basso e un cartiglio nella parte superiore.