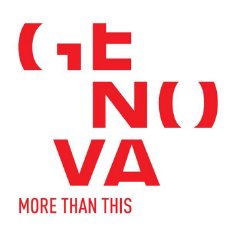Solo di recente, e grazie al rinvenimento di alcuni nuovi dati sulla vita e l’attività di Lazzaro Calvi, la produzione di pale d’altare dell’artista genovese, ben nota e tutto sommato consistente, ha trovato una valutazione attenta e obiettiva.
La stessa Deposizione di Portoria, che pure costituisce senza dubbio una delle opere migliori di Lazzaro Calvi, non ha mai ricevuto sufficiente considerazione dalla critica. Non le ha giovato innanzitutto il fatto di avere subito, probabilmente già nella seconda metà del Seicento, un drastico cambio di collocazione, cui dovettero seguire rimaneggiamenti e ridipinture, come si evince dalle brevi annotazioni di Soprani, Ratti e Alizeri, il quale descrive l’opera “non altrimenti che posticcia nella cappella per cui s’ascende alla sacristia” e “ritocca in parecchi luoghi”.
In realtà, l’incarico di provvedere alla decorazione della propria cappella, a destra del presbiterio, conferito ai due fratelli Calvi - Lazzaro e Pantaleo - dalla famiglia Cavanna, rappresentava per Lazzaro, in particolare, un’occasione molto importante e prestigiosa, che gli consentiva di misurarsi con gli artisti più in auge del momento a Genova - Giovanni Battista Castello, Luca Cambiaso, Andrea Semino -, già chiamati, ben prima di lui, a realizzare parte della decorazione della chiesa dell’Ospedale di Pammatone. Lazzaro, probabilmente non ancora sessantenne, si avvalse dunque di ogni strumento culturale a sua disposizione, cercando di mettere a frutto tutta la sapienza pittorica di cui era provvisto e suggellando il proprio impegno con firma e data (“Lazarus Calvi faciebat 1577”), che egli appose sul margine inferiore della tavola, originariamente destinata all’altare maggiore della cappella.
L’impianto compositivo - con le figure della Madre e del Figlio disposte frontalmente, lungo un’unica direttrice verticale dall’alto al basso, e con due delle pie donne che sorreggono da un lato e dall’altro le braccia di Gesù, le cui gambe inerti si piegano lateralmente ad angolo - è mutuato interamente da un’invenzione di Michelangelo degli anni Quaranta, mediata da una delle incisioni che ne vennero tratte, con ogni probabilità da quelle di Giulio Bonasone o di Nicolas Beatrizet.
La raffinata gamma cromatica è tenuta su toni smorzati, bruni e violacei, che se da un lato descrivono con consumato naturalismo l’ora del giorno in cui si svolge l’episodio evangelico trattato - quella del tramonto e dell’approssimarsi della sera -, dall’altro rivelano la scelta di Lazzaro di condividere la ricerca avviata in quegli anni da Luca Cambiaso, in dipinti quali la Pietà di Carignano, di poco precedente.
L’atmosfera di sospesa meditazione e il muto dialogo interiore fra personaggi ritratti e spettatore ben dimostrano la capacità con la quale Lazzaro seppe farsi interprete delle nuove istanze religiose, allora manifestatesi all’interno della Chiesa romana, a seguito della chiusura del lungo dibattito tridentino. Non può essere trascurata, a tale proposito, la presenza dei Gesuiti in quegli stessi anni all’Annunziata di Portoria: essi infatti, insediatisi in città già da qualche tempo, officiarono la chiesa per circa un trentennio, prima di trasferirsi nell’attuale chiesa del Gesù.