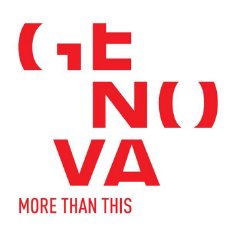Clicca qui per visualizzare l'immagine
I Teli della Passione in tessuto jeans
Dipinto
Fibra di lino tinta con indaco e dipinta a biacca
Per Vassili Kandinsky il blu era un impulso dell’uomo alla ricerca della sua natura intima: un colore che attira l’uomo verso l’infinito e risveglia un desiderio di purezza e una sete di soprannaturale. Lo stesso pensiero deve essere stato inconsciamente condiviso dai committenti dei teli, concepiti per raffigurare la Passione di Cristo.
Le tele blu, dipinte a monocromo, si collocano in un punto difficilmente precisabile tra devozione popolare e arte colta: provenienti dall’abbazia di San Nicolò del Boschetto in Val Polcevera, sono realizzati in fibra di lino tinta con indaco e dipinti a biacca (tempera bianca a base piombo) e possono essere considerati a pieno titolo illustri antenati delle tele di Genova o jeans. Si tratta di quattordici teli databili tra il 1538 e la fine del XVII secolo. Si ispirano alle incisioni di Albrecht Durer raffiguranti la Piccola Passione pubblicate nel 1508-1512. Acquistati nel 2001 dallo Stato Italiano, fanno parte della Collezione tessile della Soprintendenza della Liguria che li ha collocati in deposito temporaneo presso il Museo Diocesano. Gli studi più recenti ritengono che questi teli costituissero il “sepolcro” o altare della Reposizione, ossia un apparato effimero per la Settimana Santa: venivano probabilmente allestiti in chiesa a formare una piccola cappella per la devozione dei fedeli.