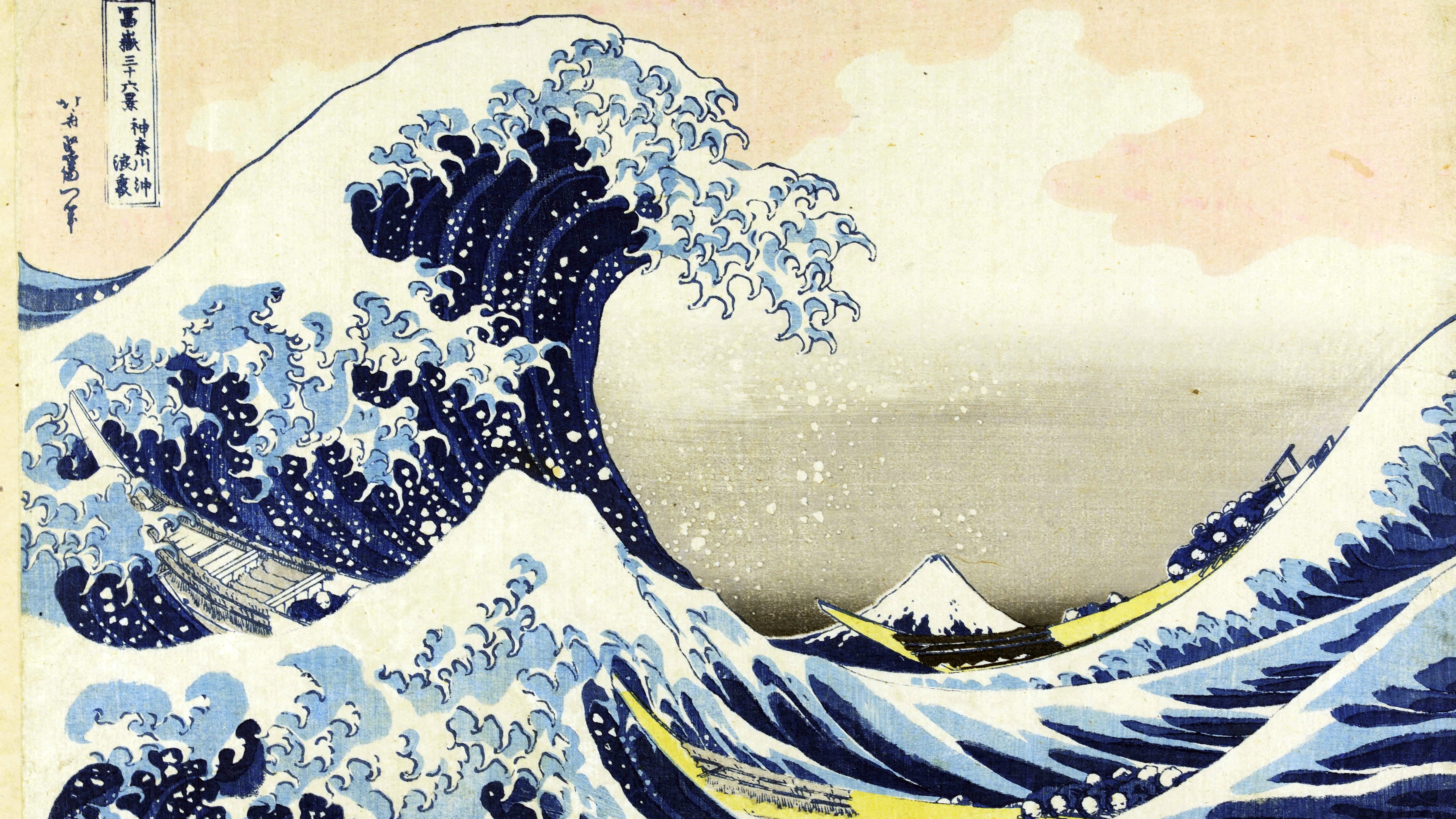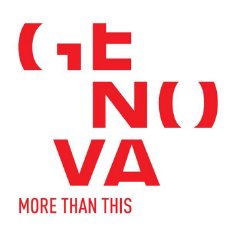Clicca qui per visualizzare l'immagine
Ragazzo con conchiglie dalla Caverna Pollera
Sepoltura
Ossa umane, conchiglie, lastre di pietra
E’ un ragazzo di circa 18 anni vissuto nella Caverna della Pollera 6500 anni fa circa. E’ stato sepolto all’interno di una cassa di lastre di pietra di grandi dimensioni, lastre coprivano anche le gambe ma non la parte superiore del corpo. Sono presenti anche blocchi di medie e piccole dimensioni.
Il ragazzo è sdraiato sul dorso con le gambe flesse lateralmente e il braccio sinistro posto sotto la testa, in una posizione tipica della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata che si sviluppa nel pieno Neolitico in Liguria e in parte dell’Italia Settentrionale.
Sopra le lastre di pietra sono presenti numerose conchiglie (Spondylus, già Triton ora Charonia, Glycimeris, Cardium) raccolte sulle spiagge e lavorate nella grotta per realizzare monili, attrezzi, trombe, ami.