
Clicca qui per visualizzare l'immagine
Ritratto di Georg Wrangel
Olio su tela, cm. 131 x 97

Clicca qui per visualizzare l'immagine
Ritratto di Georg Wrangel
Olio su tela, cm. 131 x 97


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Anton Von Maron (Vienna, 1733 - Roma, 1808)
Olio su tela, 133 x 97 cm
La dama raffigurata in questo ritratto di Anton von Maron, pittore viennese allievo di Mengs, è la moglie di Anton Giulio II Brignole - Sale, Anna Pieri Brignole, vivace e colta esponente del patriziato senese, sposa dell’aristocratico genovese nel 1786. Trasferitasi a Genova in un nuovo appartamento all’ultimo piano di Palazzo Rosso (oggi chiuso al pubblico in attesa di restauro), la nobildonna senese ospiterà nel suo salotto gli intellettuali illuministi del tempo. Spesso a Parigi, Anna Pieri sarà ammessa come dama di palazzo alla corte di Maria Luisa d’Austria, seconda moglie di Napoleone, ottenendo da Bonaparte il titolo di contessa e per i figli prestigiose cariche. Von Maron, conosciuto per essere stato il ritrattista ufficiale della corte austriaca, eseguì il dipinto, caratterizzato da un’evidente sensibilità tardo-settecentesca e da uno stile aggraziato e prezioso, durante un soggiorno genovese della dama nel 1792.


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Ritratto di Maria Brignole Sale con il figlio Filippo
Brignole-Sale De Ferrari Maria 1889 Genova - donazione
Cogniet, Léon
dipinto
1856 - 1856 - XIX
PB 12
olio su tela
Maria Brignole-Sale De Ferrari, duchessa di Galliera, fu uno dei personaggi più munifici per la città. Ultima discendente della nobile casata dei Brignole-Sale, ella trascorse gran parte della vita a Parigi, dove il marito, Raffaele De Ferrari, uomo di finanza tra i più abili, fortunati e ricchi del suo tempo, svolgeva la sua attività. Dopo la sua morte, essendo in possesso di un immenso patrimonio e non avendo di fatto eredi, dal momento che l’unico figlio che le sopravvisse, il secondogenito Filippo, rinunciò al cognome e, con esso, all’eredità familiare, la duchessa si dedicò a grandi opere di beneficenza fondando asili, ospedali (l’ospedale Galliera è ancor oggi il secondo di Genova) e orfanotrofi, sia in Francia che a Genova. Nel 1874 fece dono al Comune di Genova di Palazzo Rosso, la dimora avita dei Brignole-Sale, con le collezioni d’arte che esso conteneva, a perenne testimonianza della magnificenza della famiglia; a questo atto seguirà il legato testamentario (1889) che concederà alla città anche Palazzo Bianco e un’altra ricca collezione di dipinti e sculture. Léon Cogniet, ritrattista estremamente affermato in Francia in quegli anni per la sua capacità di evocare l’intima personalità del modello, la ritrae nella sua prestigiosa dimora parigina, l’Hôtel de Matignon, oggi residenza ufficiale del Primo ministro francese, mentre tiene in grembo, appoggiato sulla antica Bibbia Brignole, il suo secondogenito, Filippo. Quasi noncurante di lui, Maria volge uno sguardo carico di malinconia verso il busto di marmo che si scorge riflesso nello specchio in fondo alla parete; esso raffigura Andrea, il primogenito, morto quattordicenne, cui pure la rosa posta sull’inginocchiatoio allude, come segno di tenero fiore, destinato a perire. Il dipinto raffigura la Duchessa di Galliera con il figlio, entrambi su di un divano; il bambino è posto a sinistra del quadro e si sorregge sulle braccia, che pone sopra un libro aperto sulle ginocchia della madre. Sulla destra è dipinto un inginocchiatoio con due angeli cariatidi, poco più in alto si intravede un busto in marmo. Alle spalle dei due un grosso specchio riflette la scena di un paesaggio boscoso; ai piedi della donna troviamo un tappetto persiano e una pelle di leopardo; sopra un cuscino vicino è disegnato un piccolo cane.


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Hyacinthe Rigaud (Perpignan, 1659 - Parigi, 1743)
Olio su tela, 101,5 X 80 cm
Questa aulica e raffinata immagine è stata realizzata nel 1739 da Rigaud, ritrattista ufficiale del re di Francia Luigi XV, in occasione del soggiorno a Parigi di Gio. Francesco II Brignole - Sale in qualità d’ambasciatore della Repubblica di Genova. L’artista, a partire dall’ultimo decennio del Seicento, aveva iniziato a lavorare come ritrattista esclusivamente per la corte del Re Sole, elaborando un modello di ritratto ufficiale vivace e insieme solenne nel taglio e nella composizione, a mezza figura o a figura intera, sullo sfondo di modelli architettonici e paesistici.
Nella sua opera appare evidente una attenta riflessione sui modelli di Anton van Dyck, rielaborati però in impianti di maggior rigidezza e austerità.
Il ritratto di Palazzo Rosso – il cui pendant raffigurante Battina Raggi, moglie di Gio. Francesco II, non fu eseguito dal vivo, ma in effige – è stato realizzato per soddisfare un evidente intento autocelebrativo da parte del committente, che desidera perpetuare la memoria di sé e della sua nobile famiglia.
Il gentiluomo è stato ritratto di tre quarti e indossa, sopra la corazza da parata, un manto di prezioso velluto dai freddi toni viola-rosati su cui la luce riflessa crea effetti di raffinato cangiantismo. Sullo sfondo si vede un lussureggiante paesaggio e a destra una colonna di candido marmo, elemento spesso presente anche nei ritratti di Van Dyck, con una precisa connotazione simbolica: rimanda, infatti, pur genericamente a un lussuoso palazzo gentilizio divenendo allusione al potere e alla ricchezza del protagonista.
Rigaud. Francesco II Brignole Sale (foto Visconti 2011)


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Giovanni Battista Chiappe (Novi Ligure, 1722–1766)
Olio su tela, cm. 260 x 176


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Carlo Antonio Tavella (Milano, 1668 - Genova, 1738)
Olio su tela, cm. 235 x 160
Dopo una giovanile formazione milanese, a partire dal 1688 Tavella soggiorna in Emilia e Toscana e, probabilmente, a Roma dove tuttavia la sua presenza non è direttamente documentata, accostandosi a quel filone di pittura di paesaggio più classicista e arcadico che vedeva in Gaspard Dughet il principale riferimento.
Tornato a Milano nel 1695 si lega a Pieter Mulier detto il Tempesta fino alla morte di quest’ultimo, nel 1701; a partire da questa data si trasferisce definitivamente a Genova, città di origine della sua famiglia. Nella città ligure, d’altra parte, aveva già eseguito tra il 1691 e il 1692 i tre paesaggi ad affresco (in origine quattro) per le pareti della sala delle Arti liberali del palazzo Brignole - Sale, l’attuale Palazzo Rosso, prima testimonianza della sua attività artistica.
Sempre per la famiglia Brignole - Sale realizza nel 1729 due vedute del feudo di Groppoli, possedimento situato in Lunigiana sulla sponda destra della valle del Magra che, nonostante si trovasse entro i confini del granducato di Toscana, diede il titolo di marchese alla famiglia genovese fin dal XVII secolo. Nel museo si conservano le due differenti versioni di questo soggetto, entrambe direttamente commissionate da Gio. Francesco II.
Il dipinto in questione, di dimensioni maggiori, già andato disperso a seguito delle vicende ereditarie della famiglia, è ricomparso sul mercato antiquario solo in tempi recenti ed è frutto di una acquisizione del Comune di Genova (2004), con finanziamento della Compagnia di San Paolo.


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Jacopo Antonio Boni (Bologna, 1688 - Genova, 1766)
Olio su tela, cm. 266 x 179
Nel marzo del 1746 Gio. Francesco II Brignole - Sale fu eletto doge della Repubblica di Genova e il pittore bolognese Jacopo Antonio Boni, già attivo per lavori ad affresco a Palazzo Rosso nel 1744-1745, fu incaricato di dipingerne l’immagine ufficiale. Il modello compositivo dell’immagine ricalca pedissequamente nella posa di tre quarti – pressoché identica – e nell’ambientazione una delle opere più celebri e famose del pittore parigino Hyacinthe Rigaud, il Ritratto di Luigi XIV, realizzato nel 1701 (Parigi, Louvre). Lo stesso Rigaud nel 1739 aveva eseguito un ritratto di Gio. Francesco II in occasione dell’andata a Parigi di questi in qualità di ambasciatore e, precedentemente, nel 1704, aveva effigiato anche il di lui padre, Anton Giulio. La scelta di rifarsi al prototipo dedicato al potente monarca francese evidenzia chiaramente l’intento celebrativo del committente, che è raffigurato con un sontuoso manto regale, la mozzetta di ermellino e il bastone del comando all’interno di un’imponente scenografia creata dal tendaggio a baldacchino e dallo scorcio della colonna binata che apre su il paesaggio dello sfondo, in cui è abbozzato l’episodio della battaglia della Bocchetta.
Il dogato di Gio. Francesco II, infatti, incorse durante i drammatici fatti storici del 1746 – quelli che ebbero come protagonista il mitico Balilla – quando a Genova, invasa dalle truppe austro-piemontesi, scoppiò una rivolta popolare che portò alla cacciata del nemico e alla liberazione della città. La scritta sulla lettera appoggiata al tavolino, che recita: “pro patria/et libertate”, la maschera di Giano bifronte sul plinto della colonna e l’armatura ai piedi del doge risultano quindi tutti elementi che, oltre a personalizzare il dipinto, alludono agli avvenimenti coevi e al difficile ruolo ricoperto da Brignole - Sale a salvataggio delle istituzioni repubblicane da lui rappresentate.


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Domenico Piola (Genova, 1627-1703)
Domenico Piola dipinse le volte delle ultime due stanze di levante del secondo piano nobile di Palazzo Rosso fra il 1687 e il 1688, come attestano i saldi dei pagamenti che lo riguardano.
È il periodo successivo al suo ritorno dal viaggio-fuga intrapreso nel 1684, a seguito del bombardamento francese della città, che lo portò in varie località del Nord Italia e soprattutto a Parma, dove ebbe modo di confrontare e di aggiornare sulle soluzioni correggesche il suo modo di concepire lo spazio dipinto in rapporto a quello architettonico. Questa esperienza, e, insieme, il contatto con Gregorio De Ferrari, suo genero e allievo, conferì al suo linguaggio una più sciolta leggerezza, soprattutto nella pratica di un uso del colore più lieve e meno corposo, cui si associa il gusto per lo spazio aperto e per la composizione intesa in senso ruotante.
Sono elementi ravvisabili nella concezione delle sale con le allegorie di Autunno e Inverno, dove Domenico si avvalse della collaborazione dello stuccatore Giacomo Muttone e del quadraturista bolognese Stefano Monchi.
Nella sala dell’Inverno, Piola attua una assoluta libertà nella impaginazione dello spazio. Al plastico intrecciarsi dei corpi dei venti invernali, si contrappone Inverno, eccezionalmente giovane e vestito di chiaro, che si scalda al braciere, con alle spalle Marzo o Favonio, mentre le allusioni al carnevale e alla caccia, arricchite di animali e personaggi esotici, movimentano i margini della volta, a stento contenute da una possente balaustra dipinta. Scene di banchetti, musicanti, ozio, giocose risse, o giochi di fanciulli, rendono complessivamente viva e dinamica la lettura di questo affresco, dal punto di vista sia tematico sia della percezione dello spazio dipinto, effetto accentuato dalle prospettive architettoniche a trompe-l’oeil di Nicolò Codazzi sulle pareti.


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Giovan Battista Gaulli, detto il Baciccio (Genova, 1639 - Roma, 1709)
Olio su tela, cm. 128,5 x 96,7


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Il viaggio di Abramo
Maria Brignole-Sale De Ferrari 1874 Genova - donazione
Grechetto, Castiglione Giovanni Benedetto
dipinto
1652 - 1655 - XVII
PR 92
Unità di misura: cm; Altezza: 186; Larghezza: 282
olio su tela
Il genio di G.B. Castiglione il Grechetto - Genova - 1990
Ottomani, Barbareschi, Mori nell'arte a Genova. Fascinazioni, scontri, scambi nei secoli XVI-XVIII - Genova - 2024-2025
La tela è citata già nell'inventario della quadreria di Giovanni Francesco I Brignole-Sale, compilato entro il 1684. In esso, tuttavia, le misure dichiarate corrispondevano a un ingrandimento atto a inserire l'opera in una quadratura di una sala del primo piano nobile della residenza di famiglia sita in Strada Nuova. L'opera subì poi altre modifiche in occasione della sua traslazione al secondo piano, e solo nel secondo dopoguerra venne riportata alle dimensioni originali. La presenza della firma e di una datazione mutila che presenta ad oggi solo le prime due cifre, ma trascritta in precedenza come "165[-]", consente il confronto del dipinto con altri realizzati da Grechetto negli anni Cinquanta del XVII secolo. Questi dati hanno permesso l'avanzamento di una datazione relativa alla conclusione del secondo soggiorno romano dell'artista, facendo riferimento in particolare al rientro a Genova dopo l'agosto 1651. Conseguenzialmente ai tragici esiti della peste che colpì la città tra 1656 e 1657, Grechetto si trasferì prima a Venezia e poi a Mantova presso i Gonzaga. Nella tela in esame è ormai evidente l'influenza di Rembrandt, soprattutto se si osserva il repertorio di teste con turbante di cui Castiglione si serve per evocare l'affastellamento del popolo ebraico in viaggio (Genova 2024, cat. 28, pp. 238-240). Il soggetto della composizione fa parte dei cosiddetti esodi biblici. In particolare, la tela raffigura, insieme a Sara e Agar con Ismaele in grembo, Abramo che si appresta a lasciare la città di Ur per recarsi a Canaan. Il taglio diagonale della scena permette di percepire il movimento della carovana costituita da donne e uomini, bestiame e oggetti di vario tipo: un espediente che permette al pittore di esercitare la propria abilità pittorica liberamente, nonostante quello trattato fosse un tema sacro.


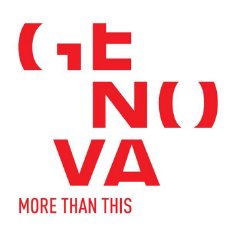

Sede:
Comune di Genova - Palazzo Tursi
Via Garibaldi 9 - 16124 Genova
C.F. / P.iva 00856930102