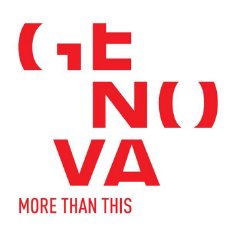Clicca qui per visualizzare l'immagine
Mazzini Maria
Induno, Gerolamo
dipinto
1851 - 1890 - XIX
41
Unità di misura: cm; Altezza: 90; Larghezza: 69
Tela-olio
Maria Drago, conosciuta come Maria Mazzini dopo il matrimonio con Giacomo Mazzini, nacque nel XVIII secolo e fu madre di quattro figli, tra cui Giuseppe Mazzini. Donna colta e profondamente religiosa, fu un punto di riferimento affettivo e morale per il figlio, che le fu sempre legatissimo. La sua influenza fu determinante nella formazione del pensiero etico e patriottico di Giuseppe. Nata a Pegli (allora comune autonomo) nel 1774, morì a Genova il 9 agosto 1852, durante l’esilio del figlio, che ne pianse profondamente la perdita.
Il ritratto di Maria Mazzini è un’opera intensa e sobria, che la raffigura in età matura. L’abbigliamento semplice e scuro, privo di ornamenti, sottolinea la sua riservatezza e il ruolo di madre devota, figura silenziosa ma fondamentale nella formazione del figlio. L’opera si inserisce nel contesto del culto familiare e patriottico che circonda la memoria mazziniana, celebrando non solo l’eroe, ma anche le radici affettive e morali da cui è nato. Ritratto di Maria Mazzini in età matura vestita con abiti scuri, seduta e intenta a leggere un libro.