
Clicca qui per visualizzare l'immagine
Teca 3 - Rotte africane

Clicca qui per visualizzare l'immagine
Teca 3 - Rotte africane


Clicca qui per visualizzare l'immagine


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Teca 1 - I venti dell'est


Clicca qui per visualizzare l'immagine


Clicca qui per visualizzare l'immagine


Clicca qui per visualizzare l'immagine


Clicca qui per visualizzare l'immagine
Sensoriale e Sit on Sound
SENSORIALE è un luogo dove il tempo è dilatato, lo spazio accogliente, i sensi finemente sollecitati. Una postazione con singoli elementi da combinare in molteplici formazioni: 5 strumenti, una seduta morbida e un cuscino ordinati secondo il principio geometrico d’armonia della serie di Padovan. Le videoproiezioni sono frammenti di luce e fiori. L’essenza di cedro favorisce la distensione attraverso l’olfatto. SENSORIALE nasce per accogliere e per fare un’esperienza orientata verso il benessere.
RESONANCE: una pedana triangolare in legno di abete, solitamente usato per i clavicembali, sensibile alle vibrazioni del suono del sistema audio posto al suo interno
TRIXILOFONO: una serie di tre xilofoni, realizzati con tavolette in legno montati in sequenza alternata su struttura trapezoidale
16CORDE: strumento ispirato dai cordofoni dell'Est e dell'estremo Oriente, con corde montate in verticale su corpo trapezoidale
KOSHI TOWER: 4 wind chimes ispirati ai 4 elementi, il cui suono è prodotto dal movimento di una sfera in vetro su lamelle di metallo
TRICAJON: ispirato dal cajon, percussione peruviana, realizzato con 3 soli lati, uno dei quali ha un tamburo sciamanico in pelle
Progetto ideato e realizzato da Milena Fois e Davide Ferrari. A cura di Echo Art.
Liuteria di Cristiano Do Rosario. Sensori audio di Daniele Adrianopoli. Musiche di Davide Ferrari, Daniele Adrianopoli, Michele Ferrari.
Video di Milena Fois. Arredi di Musiquarium Srl. Collaborazione tecnica di Dario Fortunato.
Realizzato nell’ambito di Museo per tutti, un progetto dell’Associazione l’Abilità Onlus con il sostegno della Fondazione De Agostini.


Clicca qui per visualizzare l'immagine
L'esposizione fotografica


Clicca qui per visualizzare l'immagine
L'esposizione degli strumenti


Clicca qui per visualizzare l'immagine
L'insieme delle teche


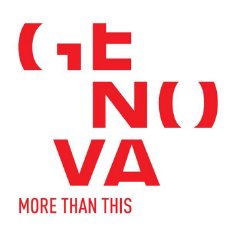

Sede:
Comune di Genova - Palazzo Tursi
Via Garibaldi 9 - 16124 Genova
C.F. / P.iva 00856930102